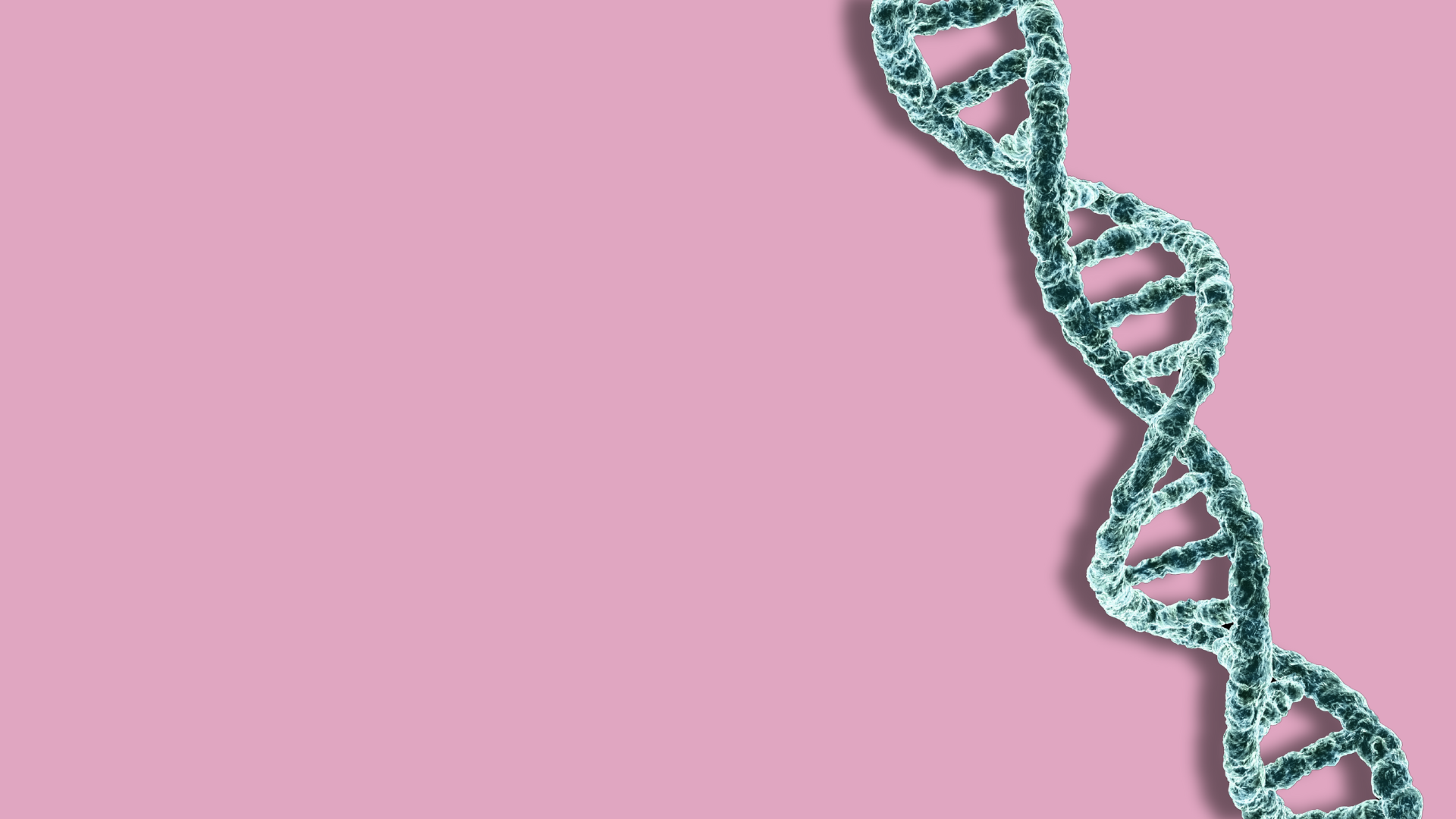Dai topi ai primati, ci siamo fatti raccontare il percorso di ricerca su nuove forme di terapia genica per l’emofilia (e non solo)
Poter curare le malattie genetiche alla radice, sostituendo un gene mutato e malfunzionante con quello corretto. È questo l’obiettivo della terapia genica, una strategia terapeutica che ha iniziato a svilupparsi in modo concreto negli anni ’80: il primo tentativo di terapia genica su un essere umano risale al 1990, quando una bambina affetta da una forma grave di immunodeficienza (nota come ADA-SCID) ricevette cellule del proprio sistema immunitario modificate con un gene corretto.
Quel primo trattamento aveva portato a un miglioramento significativo delle condizioni della paziente, anche se non era stato una cura risolutiva. Ma la ricerca è andata avanti e oggi sono diverse le terapie geniche impiegate in clinica: è il caso di quella usata per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale di tipo 1, della già citata ADA-SCID e anche alcune forme di beta-talassemia ed emofilia, per citarne solo alcune. Non per questo la ricerca si è arrestata: oltre a cercare di utilizzare la terapia genica anche per altre patologie, mira a migliorare quelle attuali, rendendole più efficaci.
Ne abbiamo parlato con Michela Milani, ricercatrice al San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (SR-Tiget), focalizzandoci sul suo lavoro di ricerca per una nuova terapia genica per il trattamento dell’emofilia.
Perché la terapia genica per l’emofilia
L’obiettivo principale della terapia genica è modificare, sostituire o integrare geni malfunzionanti per ristabilire una funzione biologica normale. Per questa ragione, le malattie genetiche per le quali il responsabile è un singolo gene mutato (monogeniche) sono da sempre le candidate ideali per questo tipo di trattamenti: integrare o sostituire un singolo gene è più semplice che cercare d’intervenire in contesti nei quali a essere coinvolti sono molti geni.
Ecco perché l’emofilia è tra le prime patologie sulle quali si è pensato d’intervenire. Questa rara malattia è causata da un difetto nella coagulazione del sangue ed è dovuta alla carenza o al malfunzionamento di specifiche proteine coinvolte nel processo di coagulazione, dette fattori della coagulazione.
Esistono due forme principali di emofilia, distinte in base al fattore della coagulazione interessato:
- l’emofilia A è la forma più comune ed è causata dalla carenza o dall’alterazione del fattore VIII;
- l’emofilia B è più rara ed è dovuta alla carenza del fattore IX.
I sintomi delle due forme sono simili: sanguinamenti prolungati dopo tagli o interventi chirurgici, emorragie spontanee nei muscoli o nelle articolazioni, dolore e gonfiore dovuti all’accumulo di sangue nei tessuti e, a lungo termine, grave artrosi.
Tradizionalmente, il trattamento dell’emofilia, soprattutto dei casi più gravi, si basa sulla somministrazione cronica endovenosa del fattore mancante, mentre l’approvazione delle prime terapie geniche (oggi disponibili in Europa sia per l’emofilia A sia per la B) ha segnato la prima possibilità di trattamento singolo con effetti a lungo termine.
Scegliere il mezzo di trasporto
Le terapie geniche possono essere somministrate direttamente nel corpo del paziente (somministrazione in vivo) oppure attraverso un prelievo e una modifica in laboratorio delle cellule da correggere, seguita dalla loro reinfusione nel paziente (approccio ex vivo). Quale che sia l’approccio, il gene terapeutico deve avere qualcosa che lo trasporti nelle cellule bersaglio: un vettore. E i virus sono degli ottimi “corrieri genetici”, perché sono naturalmente capaci di introdurre il proprio materiale genetico nelle cellule umane. Così, molte terapie geniche si sono concentrate proprio sui virus, modificati in modo da risultare innocui, come vettori.
Questi ultimi trasportano il gene terapeutico fino al nucleo della cellula bersaglio, dove può essere espresso per ripristinare la funzione biologica. A seconda del tipo di virus utilizzato, il gene può essere o meno integrato nel genoma della cellula: «La terapia genica per l’emofilia si basa su vettori derivati da virus adenoassociati (AAV), che trasportano il gene per la produzione del fattore di coagulazione nelle cellule del fegato. Questo virus per lo più non si integra nel DNA umano e, se da una parte quest’aspetto riduce il rischio d’interferenza con il genoma, dall’altro rende la terapia genica inutilizzabile in età pediatrica, quando il fegato è ancora in fase di crescita e sviluppo. A ogni replicazione cellulare, infatti, solo una delle due cellule figlie manterrà il gene corretto che non viene replicato con il resto del genoma, causando una progressiva perdita di efficacia. Ma il trattamento dell’emofilia, così come di molte altre patologie, è tanto più efficace quanto più è tempestivo, perché evita le complicanze, a volte croniche, della patologia», spiega Milani.
Per quanto preziosa per i pazienti, l’attuale terapia genica ha anche altri limiti. Per esempio, con il tempo le cellule epatiche possono perdere l’espressione del gene terapeutico, soprattutto se si rigenerano o vengono sostituite, come può accadere naturalmente nel fegato. Inoltre, il sistema immunitario può riconoscere le cellule modificate come “estranee” e danneggiarle, riducendo ulteriormente l’efficacia nel tempo. Per quest’ultima ragione, inoltre, la terapia genica può essere eseguita un’unica volta: la presenza di anticorpi contro il vettore AAV renderebbe una seconda infusione inefficace.
«Per tutte queste ragioni, la nostra linea di ricerca si è concentrata su una strategia complementare, basata sull’utilizzo di un altro vettore, stavolta derivato dai lentivirus, una sottoclasse di retrovirus, di cui fa parte anche HIV. A differenza dei vettori AAV, quelli lentivirali sono in grado di integrare il gene trasportato direttamente nel genoma della cellula. Questo significa che, una volta inserito, il gene può essere mantenuto anche quando la cellula si divide, garantendo un’espressione più duratura e stabile nel tempo», spiega Milani. «Naturalmente, anche i vettori lentivirali sono modificati per non causare malattie e, inoltre, per ridurre al minimo le possibili interferenze con il genoma umano».
Dal topo ai primati: studiare la terapia genica negli animali
«Il percorso di studio di questa strategia, focalizzato sul trattamento dell’emofilia B, è iniziato ormai diversi anni fa. Le prime ricerche sono state condotte su topi geneticamente modificati per simulare la patologia, nei quali il gene che produce il fattore di coagulazione IX è stato inattivato», racconta la ricercatrice. La pubblicazione di questi primi studi risale al 2007: è stata la prima dimostrazione dell’efficacia e della sicurezza di questa forma di terapia genica.
Ma, come abbiamo già avuto modo di spiegare, se il topo è un buon organismo modello sotto vari aspetti, ha anche alcuni limiti. Per esempio la breve durata della vita, che nel contesto della terapia genica rende difficile studiare gli effetti a lungo termine. «Per questa ragione, allo scopo di avvicinarci ai trial clinici per la sperimentazione umana, il secondo passo è stato quello di lavorare con i cani», spiega Milani. A differenza dei topi, i cani possono presentare anche naturalmente l’emofilia: non sono stati quindi generati degli individui geneticamente modificati per simulare la malattia. Attenzione, ciò non significa che non vi sia l’intervento umano. Nel contesto di questo tipo di ricerca, infatti, non è possibile attendere casi spontanei della patologia; invece, i ricercatori fanno riprodurre in modo selettivo individui portatori, così che una parte dei cuccioli nasca con l’emofilia.
«Questa malattia è più grave nei cani che nei topi: i cani, infatti, giocano, corrono e s’impegnano in una serie di attività che comportano un aumentato rischio di traumi, che possono essere letali con l’emofilia, così come per gli esseri umani. Con la terapia genica di fatto sono stati curati: il nostro follow up è durato circa dieci anni, durante i quali i cani non hanno più avuto bisogno di ricevere un trattamento profilattico con fattori della coagulazione canini e il numero di sanguinamenti spontanei si è drasticamente ridotto», racconta Milani. È interessante notare come questo sia uno dei casi in cui i risultati di uno studio possano avvantaggiare, potenzialmente, due specie: sapendo infatti che la terapia genica è efficace nei cani, potremmo pensare di utilizzarla anche per loro, realizzando un vettore che contenga lo specifico gene canino. «In effetti, a seguito della pubblicazione della nostra ricerca, abbiamo ricevuto varie richieste d’informazione da parte di proprietari di cani emofilici in questo senso. Purtroppo, il limite è a oggi economico; oltretutto, la medicina veterinaria non è coperta dal sistema sanitario nazionale e questo trattamento avrebbe costi proibitivi per qualsiasi proprietario».
Infine, il gruppo di ricerca ha iniziato il lavoro sui primati, in assoluto i nostri parenti più prossimi e più simili, e che rappresentano un passaggio richiesto anche dalla normativa sui nuovi trattamenti. «Per portare ulteriormente avanti la terapia, abbiamo modificato specifiche proteine della superficie dei vettori lentivirali, così fossero più protette dal riconoscimento del sistema immunitario», continua la ricercatrice. È ciò di cui parlavamo prima: se il sistema immunitario non riconosce il vettore come estraneo, si riduce anche il rischio di reazioni avverse e che il gene terapeutico venga riconosciuto come estraneo.
I nuovi vettori modificati sono stati paragonati con quelli standard, e la ricerca ha permesso di evidenziare qualcosa di particolarmente importante che, senza i test sui primati, non sarebbe stato possibile osservare. «Non solo gli studi ci hanno permesso di confermare la sicurezza della terapia genica, ma hanno anche rivelato che l’efficacia, a parità di dose, era circa dieci volte più alta nei primati che negli altri modelli animali. Sono dunque sufficienti dosi minori di trattamento», spiega Milani. La ragione è presto spiegata: il vettore lentivirale è derivato da HIV, un virus che si è evoluto negli esseri umani, così come erano umane le molecole usate per modificarlo. E questo aspetto lo ha reso molto più efficiente quando si trattava di penetrare in cellule così simili alle nostre.
Non solo emofilia
Ora il gruppo di ricerca si sta avvicinando ai trial clinici per questa nuova terapia genica, ma non solo per l’emofilia. Uno degli aspetti preziosi di questo lungo lavoro, che ha richiesto finora oltre dieci anni, è infatti che i dati ottenuti possono essere utilizzati anche in altri contesti. O meglio, per altre patologie: «Infatti, oggi stiamo studiando questo stesso approccio nel trattamento di un’altra malattia genetica, l’acidemia metilmalonica. Anche in questo caso, si tratta di una patologia monogenica nella quale manca un enzima necessario per il metabolismo delle proteine, causando così l’accumulo nel sangue di una sostanza tossica, l’acido metilmalonico», spiega Milani. La patologia ha effetti gravi fin dai primi mesi di vita dei neonati e, nel tempo, determina anche l’insufficienza renale.
Il trattamento si basa su una dieta specifica, integratori e farmaci, ma spesso nelle forme più gravi è necessario il trapianto di fegato, a volte combinato a quello di reni se questi organi non funzionano più in modo adeguato. E, come abbiamo ripetuto più volte, la medicina soffre di una cronica insufficienza di organi disponibili per il trapianto. «La correzione del difetto genetico con la terapia genica potrebbe rappresentare un beneficio incommensurabile per le persone con acidemia metilmalonica. I dati raccolti nel corso dello studio per l’emofilia possono in vasta parte supportare anche lo studio per la terapia di questa patologia, per la quale l’approccio basato sui vettori lentivirali può essere ancora più prezioso», conclude Milani. «Abbiamo detto, infatti, che i vettori lentivirali potrebbero permettere il trattamento anche dei pazienti in età pediatrica. Un aspetto particolarmente significativo quando una malattia non permette ai pazienti di raggiungere l’età adulta – come purtroppo può avvenire con l’acidemia metilmalonica».