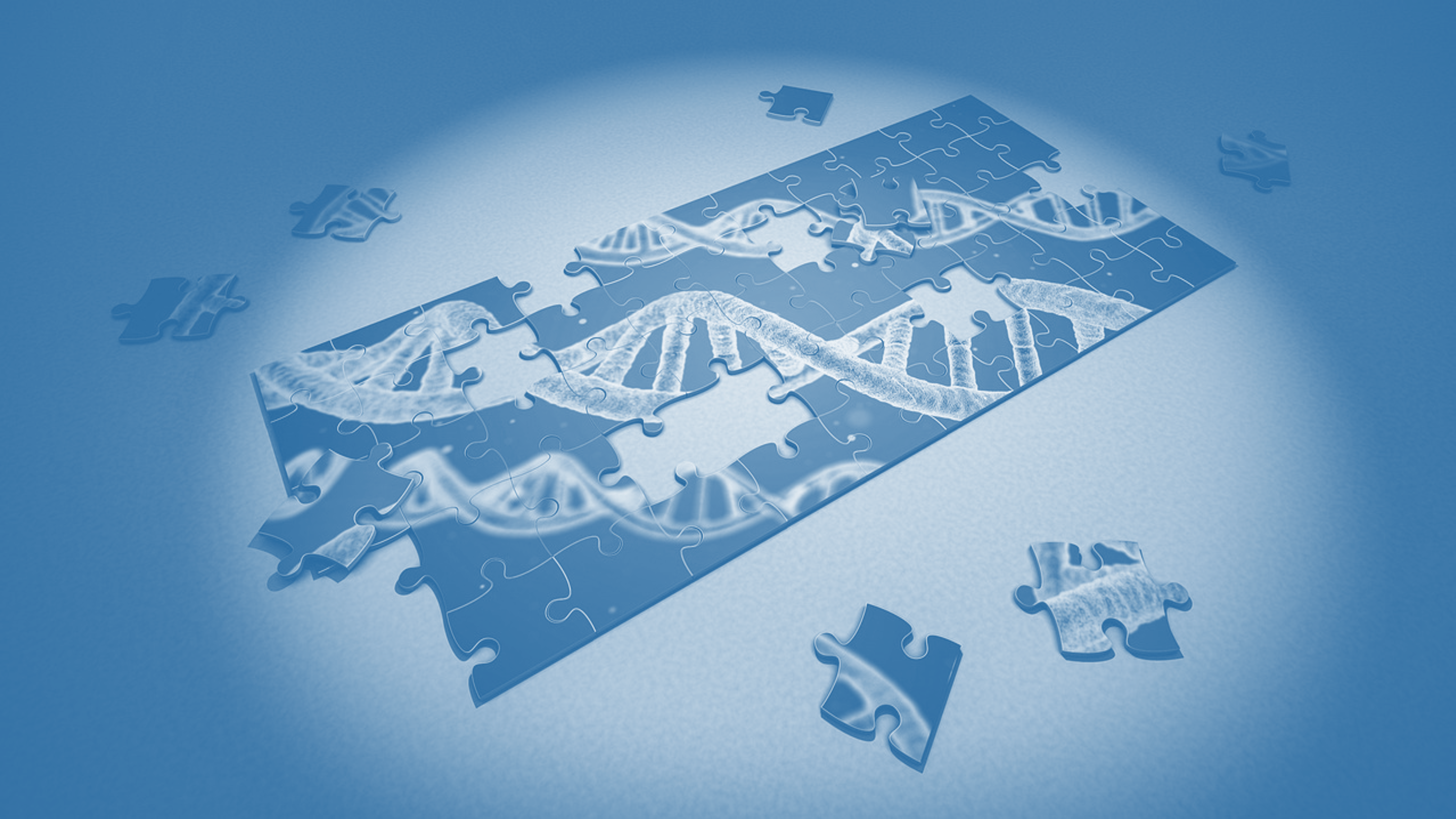Dopo aver parlato del ruolo e delle prospettive della ricerca nell’ambito della sindrome di Rett, parliamo ora con una delle associazioni italiane che si occupa della malattia, ponendo al centro delle proprie attività proprio il sostegno alla ricerca scientifica. La consigliera Rita Bernardelli ci racconta la storia dell’associazione, il suo lavoro e le ragioni che l’hanno portata a individuare nella ricerca la miglior speranza per il trattamento, se non la cura definitiva, della malattia
Pochi giorni fa, abbiamo dedicato un articolo alla sindrome di Rett – o, più propriamente, al ruolo della ricerca per la comprensione dei meccanismi e l’individuazione di una possibile terapia per questa malattia altamente invalidante e tutt’oggi priva di cura. Contesto nel quale la sperimentazione animale, seppur affiancata anche da studi condotti per esempio su colture cellulari, rimane del tutto imprescindibile.
Quando parliamo di malattie, ricerca, modelli animali, dovremmo essere sempre consapevoli che stiamo trattando argomenti profondamente concreti, che toccano in modo diretto le persone. Per questa ragione, vogliamo proseguire il filone di articoli iniziato alla fine del 2023, raccogliendo anche la voce dei destinatari finali di questa ricerca: oggi parliamo con Rita Bernardelli, una delle fondatrici e attuale consigliera dell’associazione Pro RETT Ricerca.
Vent’anni di attività per la ricerca
La sindrome di Rett è stata descritta nel 1966 dal neurologo Andreas Rett, da cui prende il nome. Ci sono voluti tuttavia diversi anni perché fosse conosciuta a livello internazionale, e ancora di più perché ne fossero identificate le cause: la scoperta che fossero mutazioni del gene MECP2 a causare la patologia, infatti, è avvenuta solo nel 1999. «Prima di questa data non conoscevamo le cause della malattia; da quel momento, finalmente sapevamo cosa studiare. L’associazione Pro RETT Ricerca nasce a pochi anni di distanza dalla scoperta, nel 2004, a partire da un ristretto gruppo di genitori le cui figlie erano malate», racconta Bernardelli. «Le nostre figlie erano piccole, e noi motivati a capire e cercare soluzioni. In Italia era già attiva un’altra associazione di riferimento per la sindrome, le cui attività all’epoca erano però dedicate soprattutto al supporto e alla gestione quotidiana delle pazienti. E, in generale, nel nostro paese la malattia non era molto studiata: noi, invece, volevamo risposte scientifiche».
I fondatori di Pro RETT Ricerca avevano dunque ben chiaro il ruolo che la ricerca avrebbe potuto (e dovuto) avere per affrontare la malattia, comprenderne i meccanismi e, da questi, individuare possibili terapie. Così, hanno iniziato innanzitutto a studiare il panorama internazionale, individuando un’attiva fondazione statunitense (fondata da Monica Coenraads, donna di origine italiana la cui figlia aveva la sindrome di Rett) con cui collaborare attraverso il sostegno attivo delle loro iniziative. «Ma volevamo riuscire ad avere un rapporto diretto con chi studiava la malattia anche in Italia. È così che ci siamo rivolte alla professoressa Landsberger, ricercatrice rientrata dagli Stati Uniti, dove si era occupata del gene MECP2 prima ancora che fosse individuato come causa della sindrome di Rett: ne è nato un rapporto stretto e la voglia di continuare ad approfondire le conoscenze del gene, cercando anche soluzioni terapeutiche».
Come abbiamo raccontato qui, Nicoletta Landsberger è oggi coordinatrice dell’Unità di ricerca San Raffaele Rett Research Center dell’Ospedale San Raffaele di Milano e del Laboratorio di Biologia Cellulare e Molecolare Applicata a Patologie del Neurosviluppo dell’Università degli Studi di Milano. Centri attivamente sostenuti dall’associazione: in effetti, quello del San Raffaele è frutto del loro impegno. Come racconta Bernardelli, infatti, «Volevamo un laboratorio interamente dedicato allo studio della malattia, e abbiamo così preso contattato nel 2010 con l’Istituto San Raffaele di Milano, che ha accettato di mettere a nostra disposizione degli spazi dedicati; la creazione dell’unità di ricerca è stata poi resa possibile grazie a un’importante elargizione liberale della Fondazione Just Italia. Oggi continuiamo a sostenere il centro soprattutto grazie ai proventi del 5×1000».
Il lavoro dell’associazione Pro RETT Ricerca, poi sfociato nella collaborazione con altri centri di ricerca sorti nel tempo in Italia (tra cui uno all’Università di Trieste e uno all’Università di Ferrara, nonché quello dell’Università di Milano coordinato sempre dalla professoressa Landsberger), ha contribuito alla pubblicazione di molti studi scientifici, che ampliano le conoscenze disponibili sulla sindrome di Rett. Oggi, quasi tutto il ricavato dell’associazione va alla ricerca; inoltre, sono state inserite alcune attività di supporto per le famiglie, come la consulenza con fisioterapisti e forse, nel futuro, un percorso di psicoterapia per aiutare ad affrontare le difficoltà psicologiche che la malattia porta nelle famiglie. Inoltre, come spesso avviene, l’associazione rappresenta un importante punto di scambio e confronto (spesso online, dato che le famiglie sono distribuite in tutto il territorio italiano) di informazioni ed esperienze.
Guardare alla ricerca come all’unica strada che possa offrire, un giorno, la speranza di cura per la malattia è stata la grande intuizione dei genitori che hanno dato vita all’associazione. Nonostante il peso di un’attesa che può essere frustrante: «Comprendere i tempi lunghi richiesti dalla ricerca scientifica non è facile: io li sto imparando a capire abbastanza bene solo ora, perché una delle mie figlie è ricercatrice di biologia molecolare e sono i racconti delle sue esperienze a mostrarmi quanto l’attesa sia a volte inevitabile, anche senza considerare eventuali complicazioni. E, d’altronde, i tempi lunghi sono necessari anche per avere tutte le conferme e offrire la massima sicurezza sui risultati», conclude Bernardelli. «La speranza è sempre che si arrivi a trovare una vera cura per la sindrome di Rett, che manca ancora nonostante i tanti avanzamenti di conoscenze che ci ha dato la ricerca. Ma, per lungo che sia, questo è l’unico percorso che possa offrire delle speranze. Sappiamo che dobbiamo proseguirlo, per le nostre figlie innanzitutto, e anche se forse alcune di loro non faranno in tempo ad assistere alla scoperta di una cura, è necessario andare avanti per le bambine che nasceranno. Avranno la possibilità di una vita migliore, anche grazie a un lungo percorso che qualcuno ha avviato per loro».